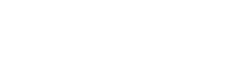Introduzione
Quando si parla di psicoterapia, tradizionalmente si intende la cosiddetta “cura delle parole”, ovvero un intervento verbale che il terapeuta mette in atto con il proprio paziente nella speranza di curare il disagio lamentato. In quest’ottica la mente è l’elemento principe dell’intervento; ma se ci fosse un’inversione? Se fosse il corpo l’elemento su cui lavorare? Questa è la proposta che portano avanti le ultime tecniche di psicoterapia, come la psicoterapia senso-motoria, ma anche pratiche che, pur non rientrando formalmente nel campo della psicoterapia, possono comunque avere un’efficacia terapeutica. Mi riferisco alla Mindfulness, che fonda le sue radici in antiche pratiche meditative, ma che, oggi, grazie alle neuroscienze, ha acquisito una nuova autonomia teorico-clinica.
Questa nuova volontà terapeutica segue, con tutta naturalezza, lo sviluppo delle neuro-scienze, che ci rivelano sempre di più l’inscindibile interrelazione mente-corpo propria dell’essere umano.
Si è passati, dunque, dalla pratica clinica tradizionale – caratterizzata da interventi di tipo Top-down, che prevedono una rielaborazione metacognitiva dell’evento traumatico – alle nuove tecniche di intervento clinico che invertono questa tendenza partendo dal basso, dal corpo, con un meccanismo di tipo Bottom-up. Il punto focale è aumentare le capacità di consapevolezza corporea, imparando prima a conoscere cosa accade a livello sensibile nel vissuto traumatico e poi a correggere o regolare queste risposte. Questo miglioramento nella risposta corporea vede poi un conseguente miglioramento anche nella sfera emotiva e cognitiva del paziente.
In ogni caso, le tecniche che utilizzano questo tipo di approccio non escludono le modalità Top-down, ma tendono a valorizzare un approccio integrato alla cura.
Il corpo nella pratica clinica
È comune a tutti l’esperienza di forte attivazione a seguito di un evento minaccioso, indipendentemente dal fatto che questo si riveli lesivo o meno.
In questi momenti, a tutto siamo disposti fuorché a ragionare; anzi, ci rendiamo conto a posteriori che il nostro cervello ha dato spazio solo a reazioni e movimenti automatici e standardizzati, fuori dalla nostra volontà.
Succede, quindi, che l’evento stressante attivi il sistema nervoso autonomo che, per dare una risposta più rapida e veloce possibile, sfugge al nostro controllo. Essendo il sistema nervoso autonomo – nelle aree sottocorticali – il primo ad attivarsi, è qui che si immagazzina il trauma e lo si registra sotto forma di espressioni somatiche, tensioni muscolari, emozioni e pattern di movimento.
Queste considerazioni trovano una formulazione nella Teoria Poli-vagale (1994) sviluppata da Stephen Porges, che specifica il ruolo del nervo vago nella risposta del SNA.
L’autore teorizza che, se l’esperienza è traumatica, il sistema nervoso rimane costantemente in uno stato di iperattivazione neurofisiologica che diviene cronica, condannando il soggetto ad una sensazione d’ insicurezza persistente.
Quindi, ancor prima di poter scegliere la tipologia di terapia da utilizzare, Bottom-up o Top-down, il corpo si impone, ricordandoci che non si può pensare di fare terapia se il paziente non rientra nello stato di attivazione fisiologico associato al senso di sicurezza. In altri termini, se il paziente non è nella cosiddetta “finestra di tolleranza”, non si possono avviare interventi di alcun tipo.
Per riportare il paziente nella finestra di tolleranza, vengono utilizzati precisi protocolli che prevedono che il soggetto ponga l’attenzione sul proprio stato di attivazione, sulla risposta corporea nel qui ed ora. L’aumento della consapevolezza corporea è “il vaso di Pandora” attraverso il quale andare a modificare gli schemi di reazioni maladattivi, che si manifestano quando il soggetto entra in contatto con il trauma.
Ed è qui che risiede il punto centrale: le risposte messe in atto sono automatiche e stereotipate, cioè non sono conseguenti a meccanismi di controllo, motivazione o pianificazione superiore. Il significato arriva dopo che la risposta è già stata implementata.
Essendo l’esperienza di natura traumatica, a queste risposte automatiche sono associate emozioni ed interpretazioni non tollerabili dal paziente, che mette in atto meccanismi dissociativi volti ad evitare il contatto diretto col vissuto traumatico.
Concentrandosi sulla componente corporea, imparando prima a riconoscerla e successivamente a controllarla, il paziente conquista l’accesso a quegli stati emotivi attivanti, permettendone la rielaborazione anche tramite i processi Top-dow, che prima non potevano avere effetto.
Ora è lecito domandarsi: perché, una volta stabilizzato nella finestra di tolleranza, il paziente non possa procedere con le tradizionali psicoterapie basate sulla parola?
La risposta è che, per poter verbalizzare l’esperienza, ci devono essere tre presupposti fondamentali, ovvero: accesso alle aree corticali, tra cui le aree del linguaggio; il trauma non deve essere antecedente allo sviluppo del linguaggio; la persona deve avere una visione integrata dell’evento.
L’approccio somatico-corporeo, inoltre, permette al paziente di restare nel qui e ora, evitando la dissociazione, in modo da riconoscere lo stato di attivazione somatosensoriale (ad essa sono legate emotività e tendenze di attribuzione di significati disfunzionali) e, in seguito, imparare a regolarlo. Così il paziente, rievocando, potrà fare esperienza del vissuto traumatico associato ad una nuova risposta corporea, che permetterà di “sbloccare” il corpo dal ricordo cristallizzato in esso.
Il trauma, ovviamente, non può essere cancellato, ma durante la nuova esperienza, avvengono modificazioni neuro-plastiche che permettono l’acquisizione di una nuova cito-architettura, la quale si attiverà in risposta agli stimoli trigger al posto di quella creata dal precedente trauma.
La consapevolezza corporea non è immediata, ma è un processo esperienziale non banale. La psicoterapia si avvale, quindi, anche di tecniche come la Mindfulness: attività nate con un intento diverso da quello clinico-terapeutico, ma che, per il riconoscimento della grande efficacia, hanno sviluppato protocolli standardizzati appositi per essere utilizzati nella pratica clinica. Nonostante l’esistenza di questi protocolli però, la Mindfulness rimane un’attività autonoma dalla pratica clinica che, se perseguita con costanza, porta benefici, capacità, strumenti e risorse, che possono essere utilizzati nella pratica clinica. La Mindfulness ha un assunto di base: “l’ascolto di ciò che il nostro corpo ci comunica deve essere gentile”. Non è una tecnica finalizzata alla critica o all’acquisizione di conoscenze per intervenire su di noi, ma consiste nell’accorgersi e nell’accettare sensazioni ed emozioni sia che esse siano spiacevoli sia che non lo siano. La Mindfulness rende chi la pratica esperto nella consapevolezza di sé, con specifico riguardo al corpo che, come dicevamo, è la base per un intervento di psicoterapia Bottom-up. Tuttavia, oltre ai benefici che ha di per sé, la Mindfulness permette anche di regolare il SNA, riequilibrando il sistema simpatico con il parasimpatico, e di favorire una visione integrata tra mente e corpo.
Al fine di semplificare e riassumere quanto sopra detto presento di seguito un esempio pratico: Immaginiamo una donna che, anni dopo un’aggressione, prova ancora ansia intensa in luoghi affollati. In terapia, la rievocazione dell’evento la porta a uno stato di distacco dal corpo, una forma di dissociazione che la protegge dai ricordi dolorosi. Qui, un approccio Top-down basato solo sulla parola è inefficace.
Con un approccio Bottom-up, invece, il paziente fa esperienza di una nuova attivazione corporea da associare all’evento traumatico. Regolando la risposta corporea quindi il paziente in contatto con il ricordo Traumatico rivive il trauma non più con l’attivazione corporea precedente ma con battito cardiaco nella norma, respiro normare e senza tensioni muscolari, Sbloccando quindi il corpo dal trauma.
Solo ora sarà possibile accedere ai livelli superiori del funzionamento psicologico e iniziare una rielaborazione narrativa del trauma.
Un ulteriore esempio ci viene fornito dall’esperienza clinica di Van der Kolk che nel suo libro “il corpo accusa il colpo” descrive il caso di una bambina abusata dalla famiglia di origine. Questa bambina, quando poi adottata, pur trovandosi in un ambiente amorevole, reagisce con panico e aggressività a gesti affettuosi provenienti da adulti.
Il suo corpo rispondeva a questi gesti con il vissuto corporeo originale associato alle esperienze di abuso subite precedentemente, attuando ancor prima reazioni di difesa automatiche.
Conclusioni
Le neuroscienze ci confermano sempre di più che l’integrazione tra mente e corpo è fondamentale e che non si può più pensare solo alle forme di terapia verbali. Adeguandosi, le psicoterapie utilizzano nuove tecniche che sfruttano questa consapevolezza, che, come descritto sopra, alle volte è l’unica possibile per la cura del trauma.
Ma al di là della cura del paziente psicologico, pratiche come la Mindfulness ci ricordano che siamo animali dotati di emozioni e sentimenti, non solo menti pensanti.
In essenza di consapevolezza corporea ed emotiva, infatti, manca un sé solido; senza un sé solido, si è in balía di regole e feedback sociali riguardo a noi e a come ci dovremmo comportare e sentire.
Accorgerci e validare ciò che sentiamo potrebbe permetterci di vivere in modo autentico, ponendo le basi per prenderci cura di noi stessi e rispettarci. Forse dopo, questo ci permetterebbe anche, così come facciamo con noi stessi, di rispettare e dare dignità all’altro per quello che è.
Bibliografia
- Damasio, A. (1999). The feeling of what happens: Body and emotion in the making of consciousness.
- Ogden, P., Minton, K., & Pain, C. (2006). Trauma and the body: A sensorimotor approach to psychotherapy. W. Norton & Company.
- Panksepp, J. (1998). Affective neuroscience: The foundations of human and animal emotions. Oxford University Press.
- Porges, S. W. (2011). The polyvagal theory: Neurophysiological foundations of emotions, attachment, communication, and self-regulation. W. Norton & Company.
- Schore, A. N. (2003). Affect dysregulation and disorders of the self. W. Norton & Company.
- Van der Kolk, B. A. (2014). The body keeps the score: Brain, mind, and body in the healing of trauma.